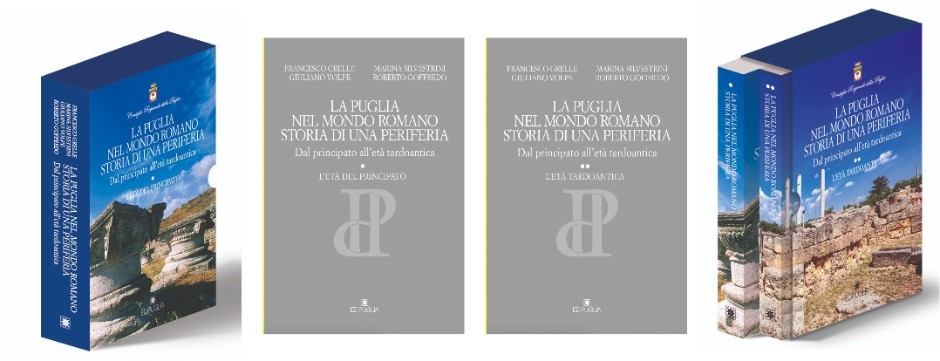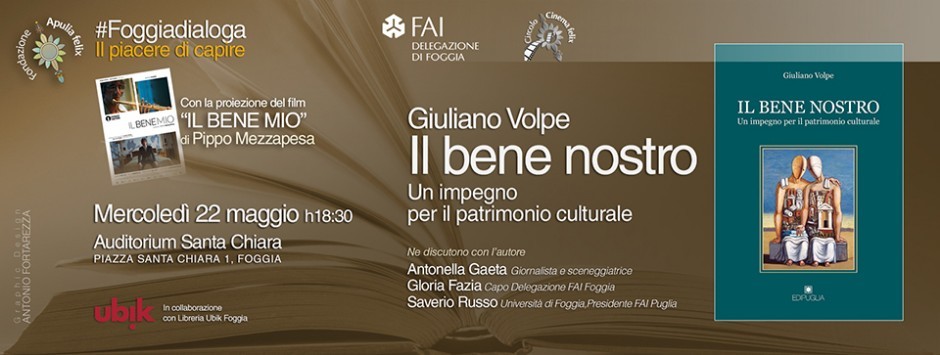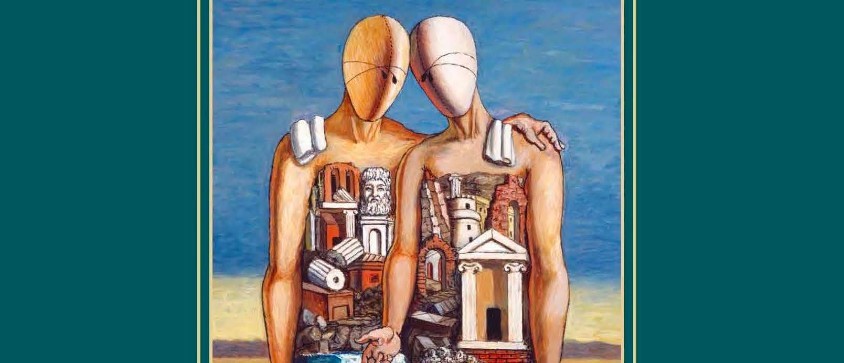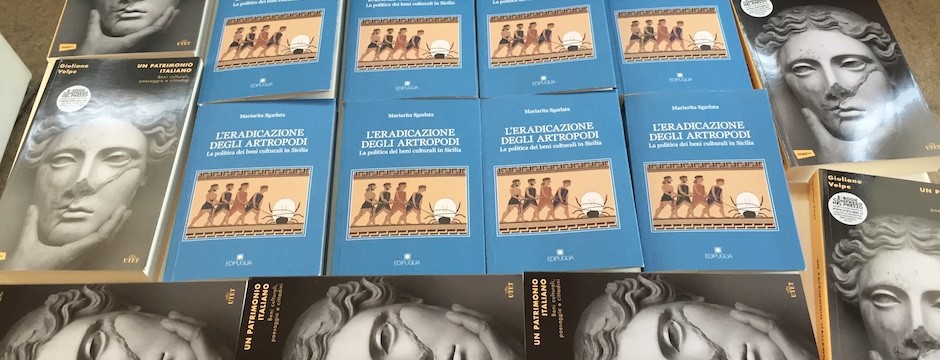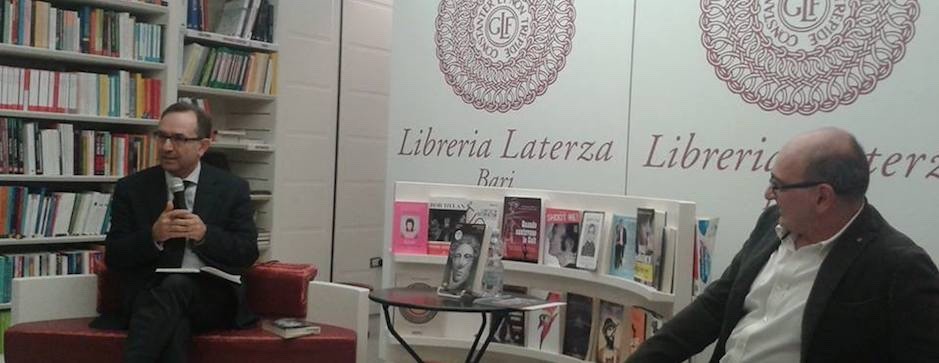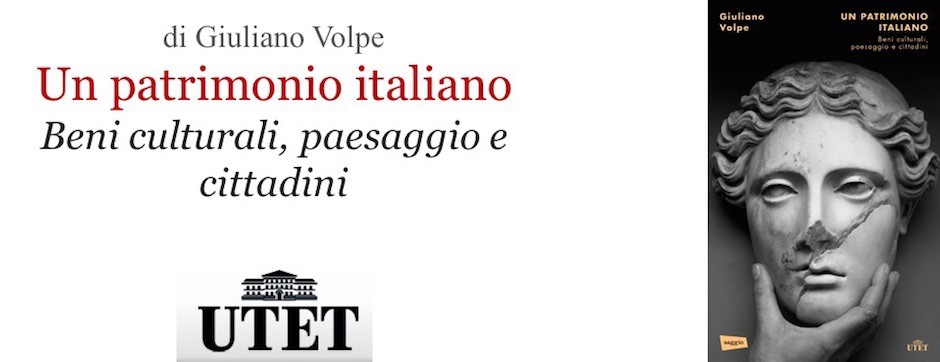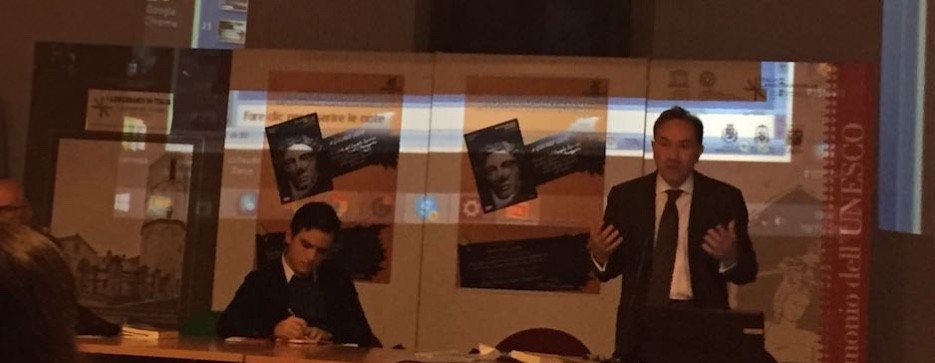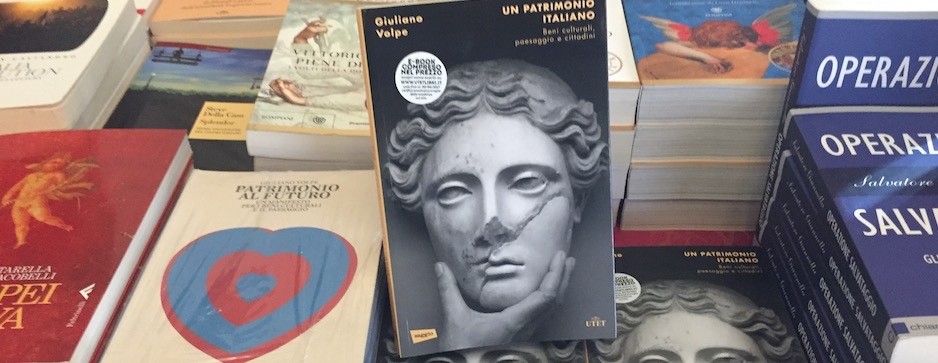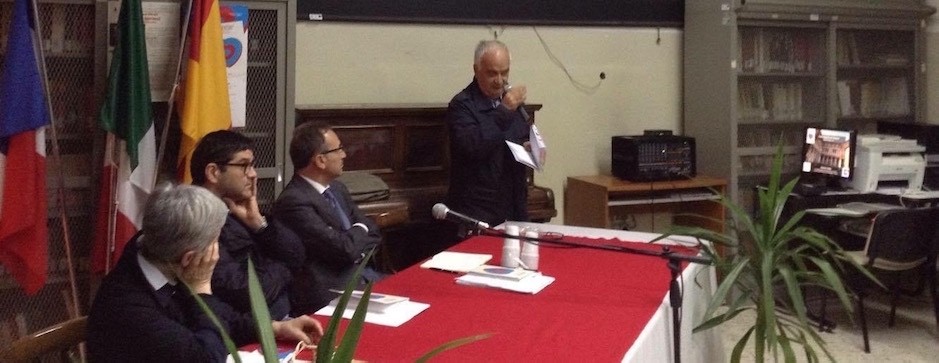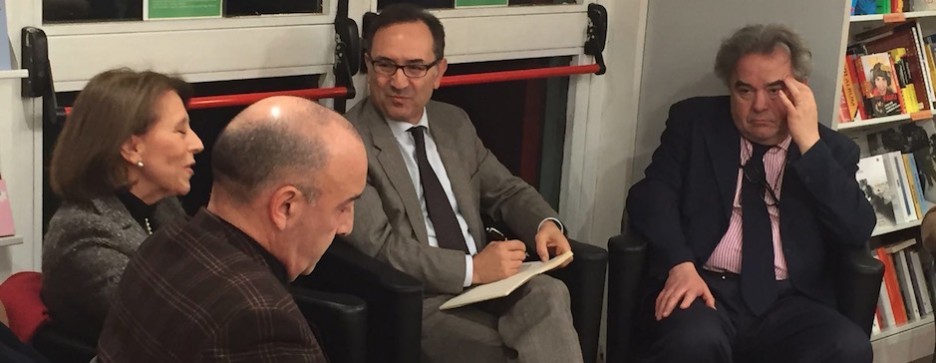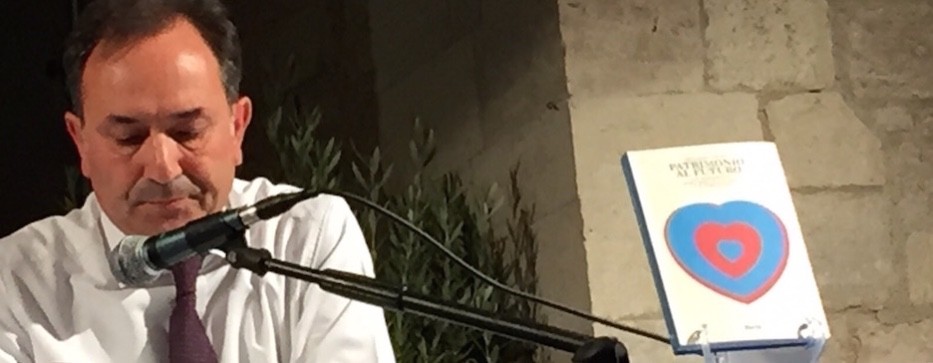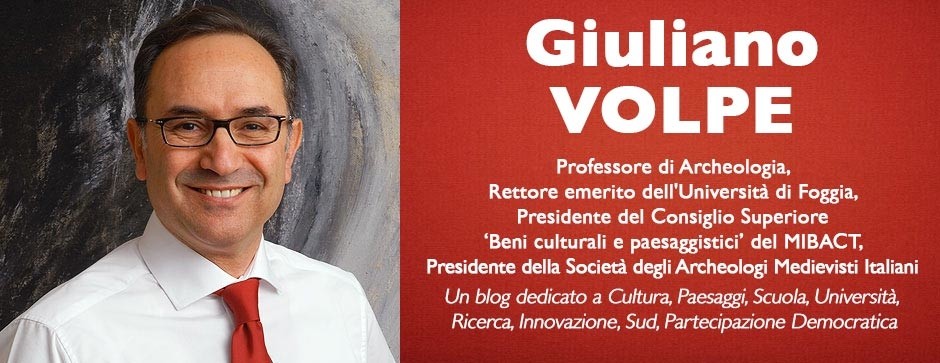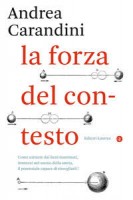Blog
La forza del contesto
Prendo le mosse da una vicenda personale. Nel 1979 ero uno studente di lettere classiche all’Università di Bari, ero indirizzato verso studi di storia antica, e ebbi la fortuna di assistere a una conferenza di Andrea Carandini sugli scavi della villa di Settefinestre, in quegli anni in corso di svolgimento, che erano comunicati anche attraverso una mostra itinerante e un catalogo, Schiavi e padroni nell’Etruria romana. La villa di Settefinestre dallo scavo alla mostra, edito dalla gloriosa casa editrice barese De Donato. In quello stesso anno usciva, per i tipi dello stesso De Donato, la seconda edizione di Archeologia e culturale materiale, dopo la prima edita nel 1975. Non ho mai nascosto che quella mostra e soprattutto la lettura di quel denso libretto ‘rivoluzionario’ furono per me, come per tanti altri allora giovani e giovanissimi studenti, la classica esperienza che ti cambia la vita.
Ecco, appunto, un libro che cambia la vita. Allora quel libro mi fece scoprire un’archeologia attenta alla ‘cultura materiale’, agli oggetti umili, alle condizioni socio-economiche dell’antichità, e quello scavo, al quale ebbi la fortuna di partecipare insieme ad un gruppo di altri studenti baresi allievi di Raffaella Cassano, mi consentirono sia di entrare a far parte della ‘generazione Settefinestre’, sia di formarmi alla moderna archeologia stratigrafica, sia di partecipare ad una ricerca incentrata su un esempio significativo del ‘modo di produzione schiavistico’ sul quale si era aperto proprio in quegli anni un ampio e vivace dibattito storiografico multidisciplinare per iniziativa dell’Istituto Gramsci, i cui esiti furono editi da Laterza. Perché parlo di quel libro e di quella fase dell’archeologia italiana e di quel momento del percorso personale e intellettuale di Andrea Carandini, e non solo, per presentare questo nuovo libro? Perché credo che si possano indicare quel libro di oltre 40 anni fa e questo del 2017 (entrambi editi qui a Bari), come, per così dire, i poli di un lungo percorso, che ha una sua coerenza, intesa con come la mera riproposizione delle stesse posizioni, delle stesse visioni, degli stessi approcci, ma come una continua ricerca, una riflessione critica e autocritica, un’interrotta capacità di innovazione. Se posso indicare una delle maggiori differenze tra questi due libri, direi che il libro del 1975 era più apodittico, più pieno di certezze, mentre questo ultimo è più aperto, più ricco di dubbi.
«La verità non sta mai tutta da una parte e neppure nelle tasche di un singolo o di un gruppetto, per cui sarebbe consigliabile apprendere anche dagli avversari» (scive Carandini a p. 24): una bella differenza rispetto ai tanti fanatici talebani che dominano la scena dei beni culturali, pontificando dalle pagine di importanti quotidiani e dai vari talkshow televisivi, con granitiche verità in tasca, certezze dogmatiche, e soprattutto con una inaudita violenza verso chi la pensa diversamente, bollato ora come un traditore, un venduto, ora come un mercificatore. Ma fortunatamente di recente la dominazione di una sorta di pensiero unico a lungo prevalente si è incrinata e si sono aperti maggiori spazi, e questo cambiamento molto deve all’iniziativa di Andrea Carandini.
Questo libro infatti è la conferma della straordinaria capacità di ricerca, di riflessione e di innovazione di Carandini, rimasta sempre fresca e effervescente come e più di quando era un giovane professore trentenne
In esso c’è anche tanta storia personale di Andrea Carandini (come nel precedente libro Laterza con Paolo Conti, Il nuovo dell’Italia è nel passato): storia personale mescolata con la storia dell’archeologia italiana dell’ultimo mezzo secolo; un racconto affascinante oltre che molto utile tanto per chi questi anni li ha vissuti quanto per i più giovani che queste vicende conoscono assai poco.
Al centro del libro c’è il paesaggio, il ‘sistema di tutti i sistemi’, secondo l’efficace definizione data dallo stesso Carandini, che guarda al paesaggio con gli occhi e con gli strumenti dell’archeologo, ma andando oltre i confini della propria disciplina, con una visione organica, unitaria, olistica.
Carandini è progressivamente passato nella sua esperienza di archeologo da una lettura stratigrafica di un singolo sito a quella di un contesto territoriale, in particolare di un paesaggio urbano complesso come quello di Roma. E non è un caso che proprio nella sua scuola sia nata e si sia sviluppata l’archeologia dei paesaggi in Italia, dove dominava una scuola di topografia assai tradizionale, ancorata ad una visione catalogica di siti e punti archeologici sulle carte. Ma il paesaggio è qualcosa di molto più complesso di una serie di punti su una carta! Non è sufficiente catalogare siti ma è necessario indagare la complessità delle relazioni. Attraverso la lettura stratigrafica di un intero territorio e la decodifica delle tracce impresse nel paesaggio attuale, ha proposto, prima nel territorio dell’Etruria e poi a Roma e nel Lazio la ricostruzione storica di sistemi insediativi, sociali ed economici, ambientali, succedutisi nel tempo.
La lezione che Carandini ci fornisce va ben al di là. Pone all’archeologo il compito di essere a diretto contatto con il paesaggio e le persone, sia quelle che hanno abitato e trasformato la porzione di territorio indagato nel corso dei millenni sia quelle che la abitano oggi. È un’esperienza che fa sentire l’archeologo non solo un ricercatore ma anche un componente di una comunità, impegnato nella conoscenza e nella tutela della memoria stratificata nel territorio, oltre che nella pianificazione e trasformazione del paesaggio attuale.
Come sempre nel percorso di Carandini, il passo dall’impegno scientifico all’impegno civile è breve; e certamente in questo caso risente della sua funzione di attivissimo presidente nazionale del FAI, cui ha dato nuovo slancio, soprattutto proponendo un’importante novità metodologica a questa benemerita associazione di cittadini: il passaggio da una tutela e valorizzazione del singolo oggetto o del singolo monumento ad una visione più ampia, contestuale appunto.
Rispetto allo scavo archeologico, che, con lo smontaggio della stratigrafia sedimentata in una porzione ristretta di un sito, è più simile ad un’operazione chirurgica, l’indagine archeologica dei paesaggi appare più vicina all’indagine clinica o all’anamnesi condotta dal bravo medico di famiglia che conosce perfettamente la storia del suo paziente ed è attento nell’individuare tutti i minimi sintomi di una malattia. Anche l’archeologo dei paesaggi deve saper leggere le tracce presenti nel corpo di un territorio, grazie ad un approccio globale e ad una vocazione multidisciplinare. Per questo l’archeologia dei paesaggi è più di ogni altra archeologia un lavoro di equipe. Solo, infatti, l’integrazione di più specialismi è in grado di giungere alla comprensione di oggetti e di fenomeni complessi, soprattutto se ogni specialismo, in quanto singola disciplina, è consapevole della propria limitatezza e sollecita confronti, interazioni, integrazioni con altre discipline, in un continuo dialogo tra saperi umanistici e tecnico-scientifici.
Il paesaggio dell'archeologo Carandini è un sistema complesso di relazioni, un flusso dinamico di processi costruttivi e distruttivi in cui trova piena espressione la dialettica tra uomo e ambiente. È l’espressione dell’evoluzione culturale, un patrimonio di immagini condivise da una comunità, un palinsesto in cui sono celate, sovrapposte, mescolate tracce risalenti di ogni epoca, alcune chiare ed evidenti, altre sfuggenti ed evanescenti: non solo insediamenti, strade, tratturi ma anche i segni del lavoro quotidiano, dei rapporti di potere, della religiosità, della cultura delle società succedutesi. Insomma, come giustamente afferma Carandini, ‘il paesaggio siamo noi’.
«Un contesto paesaggistico è un organismo naturale, agricolo-pastorale o insediativo che si è andato componendo e sovrapponendo nei millenni grazie al lavoro, all’abilità e al gusto di uomini tanto numerosi quanto a noi sconosciuti, i quali inconsapevolmente hanno determinato un ordine dovuto ad attività riproposte identiche o compatibilmente variate, che hanno conferito alla stratificazione un volto riconoscibile, al quale siano legati come a quello di una persona amata. Ne consegue che qualsiasi intervento irresponsabile e incongruo sfigura in un attimo qualsivoglia millenario contesto, trasformando significati e bellezze in deprimente disordine» (p.
I paesaggi sono, infatti, opera non di una singola persona e meno che mai di un solo artista o ma sono il prodotto delle azioni millenarie delle comunità insediate in un territorio in rapporto all’ambiente.
Così olisticamente inteso, il paesaggio perde ogni affiliazione disciplinare per emergere come il luogo della convergenza unitaria di percorsi di ricerca diversificati. Come poter leggere questo sistema complesso se non con un approccio globale? Per questo Carandini contesta la definizione, tanto di moda, di Italia come ‘museo diffuso’, preferendo quella assai più pregnante di ‘contesto dei contesti’. «Stramba è l’idea – afferma a p. 45 – che un paesaggio possa essere considerato un “museo diffuso a cielo aperto”, che è il rovescio di un contesto, perché in tal modo verrebbe da immaginarlo come una collezione di singole opere decontestualizzate, sparse in uno spazio indifferenziato … Un museo pur rispecchiando in Italia un determinato territorio da cui le opere sono state tratte, mai illustra realmente i loro contesti e dunque mai valorizza le opere dal punto di vista del suolo e della costruzione per i quali sono state generate; le rende solamente più protette e più accessibili entro uno spazio neutrale, a-contestuale, che impoverisce drasticamente la pregnanza storica e la luminosità dei capolavori mostrati tanto che il verbo ‘museificare’ conserva ancora oggi nel senso comune un significato spregiativo, che ha una sua ragion d’essere» (p. 45).
Anche in questo volume, Carandini si conferma un narratore di grande qualità, con metafore e descrizioni assai efficaci, come quando ricorre alla bella immagine del volto che «non è mai la somma di capelli, fronte, orecchi, occhi, guance, naso, bocca, mento e collo, ma una loro speciale composizione, a parole non descrivibile ma che l’occhio in un lampo riconosce ...». «Si tratta, cioè, - è sempre Carandini a parlare – del contrasto tra una cultura museale/espositiva selettiva e puntiforme, prevalente tra gli storici dell’arte e in parte anche tra gli architetti, e una cultura contestuale, prevalente fino a ora soprattutto tra gli archeologi [e qui temo che Andrea sia troppo indulgente con la nostra categoria!] che sanno operare professionalmente anche in laboratorio e sul campo. Il contrasto ideale non investe soltanto individui, ma la società civile, gli ordinamenti amministrativi, le corporazioni, le leggi e il modo stesso d’intendere la Costituzione» (p. 24). Da questa affermazione appare evidente come nel libro i temi relativi all’attuale fase di riforme, che Carandini ha sempre sostenuto con spirito critico, denunciandone anche limiti, ritardi, incongruenze, errori, ma difendendone lo spirito innovatore, siano ben presenti, con la visione di una persona che ha operato tanti anni nell’università, che è stato mio autorevole predecessore alla presidenza del Consiglio Superiore BCP, e che ora opera attivamente nel mondo del volontariato colto e della libera iniziativa della società civile.
Anche per questo, questo libro ha anche una forza etica. Come ha sottolineato Daniele Manacorda in una bella recensione, «il libro di Andrea Carandini ci aiuta così a scorgere le linee di un’etica del contesto che è quasi una forma mentale, attraverso cui la realtà ci appare come un intrico di tracce coerenti, dove le cose mute si animano e ci catturano trascinandoci nella durata del tempo e ci restituiscono l’immagine fantastica del nostro essere di ieri, di oggi e di domani, quasi come l’unica forma di immortalità possibile.»
Le idee, le suggestioni, gli spunti, le analisi, le indicazioni di metodo in questo libro sono numerosissime, tanto è denso, frutto di una riflessione pluriennale mai interrotta, capace sempre di guardare avanti, ai giovani, al futuro.
Mi limito a indicarne solo alcuni, con una selezione assolutamente incapace di proporne la ricchezza:
1) Il coraggio di guardare oltre i confini del proprio specialismo e l’invito a invadere il campo altrui, non per sostituirsi in maniera pasticciona, presuntuosa e incompetente ad altri specialismi, ma per creare dialoghi, innesti, intrecci multidisciplinari, linguaggi comuni, in grado di affrontare insieme la complessità.
2) L’interesse per le persone e non solo per le cose; una posizione significativa per un archeologo che studia la materialità della storia e ha tra i suoi meriti quello di aver introdotto in Italia gli studi sulla cultura materiale; una posizione coerente però con lo spirito più profondo dell’archeologia, che possiamo racchiudere nella celebre affermazione di sir Mortimer Wheleer, secondo cui l’archeologo quando scava non estrae dalla terra cose ma persone (If there be a connecting theme in the following pages, it is this: an insistence that the archaeologist is digging up, not things, but people). L’interesse per le persone è, però, non limitato al passato ma è rivolto soprattutto alle persone di oggi, ai cittadini, a quelal moltitudine per nulla indifferenziata di visitatori di un museo, di un monumento o di un sito archeologico: di qui l’attenzione alle diverse categorie di visitatori, al tema della valorizzazione intesa come scoperta del valore del patrimonio e di restituzione di senso ai resti del passato, con un atteggiamento assai distante, anzi decisamente contrario a certe visioni elitarie del patrimonio culturale. Lo slogan «Love people as much as you love places» del National Trust, fatto proprio dal FAI, credo che indichi bene questo modo di intendere la gestione dei luoghi della cultura.
3) L’attenzione alle piccole cose quotidiane, agli oggetti di casa, alle storie delle famiglie; in questo approccio come non scorgere una perfetta sintonia con le posizioni di Orhan Pamuk nel suo decalogo di un museo che racconti storie quotidiane: «Siamo stati abituati ad avere i monumenti, ma quello che ci serve sono le case. Nei musei avevamo la Storia, ma quello che ci serve sono le storie. Nei musei avevamo le nazioni, ma quello che ci serve sono le persone».
4) La sottolineatura della centralità della manutenzione programmata, vero asse portante dell’azione di tutela, con una stretta connessione tra monumenti, siti e ambiente, secondo la lezione, purtroppo inascoltata, di Giovanni Urbani, in decisa alternativa alla logica prevalente nel nostro Paese del restauro.
5) La stretta connessione tra studio, ricerca, insegnamento e impegno civile, culturale, sociale: una costante nel percorso di Carandini che è divenuta ancor più pregnante in questi ultimi anni.
Mi fermo qui, anche se molte altre sarebbero le cose di dire. Ma preferisco concludere con l’augurio a questo libro di poter essere, come il suo lontano predecessore del 1975, uno di questi libri che cambiano la vita ai giovani che oggi studiano la storia, l’archeologia, le varie discipline del patrimonio culturale, ai quali più che ad altri questo bel libro mi sembra indirizzato e verso i quali Andrea (e tutti noi con lui) sente una particolare responsabilità.
Intervento tenuto il 15 settembre 2017 alla Libreria Laterza di Bari, per la presentazione del libro di A. Carandini, La forza del contesto, Laterza, Roma-Bari 2017, con Alessandro Laterza e Luciano Canfora.
Ultimi post
Norimberga
Stasera ho visto un bel film: Norimberga, di James Vanderbilt. Film storico perché tratta un momento davvero storico come il processo di Norimberga, ma...
Father Mother Sister Brother
Ho visto al cinema “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch. Un bel film, molto poetico, che però ti lascia un senso di tristezza e a...
All Her Fault
Su suggerimento di un amico, con il quale condivido, oltre che per l'archeologia, anche la passione per il cinema, abbiamo visto su Sky All Her Fault, miniserie...
Tutto in un’estate!
Abbiamo visto su Prime un delizioso film francese, come sanno essere certi film francesi, "Tutto in un’estate!" di Louise Courvoisier. Ambientato nella...