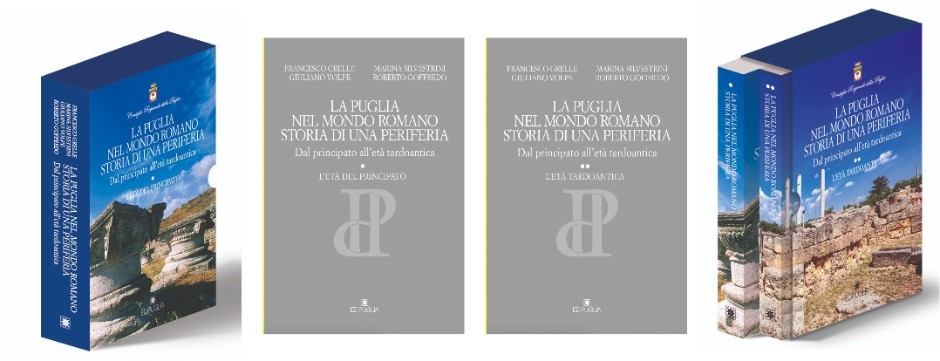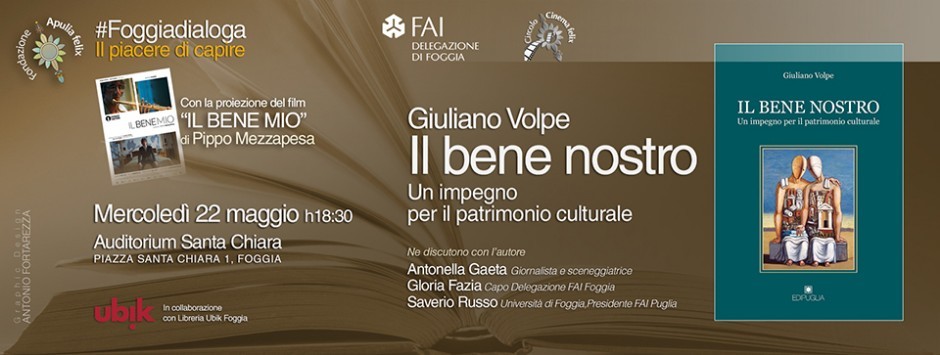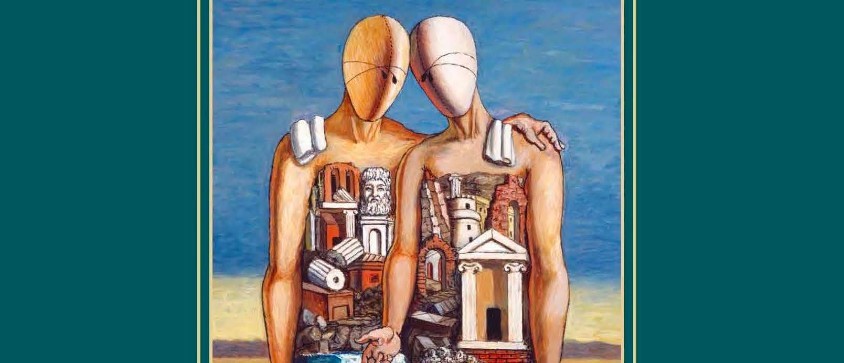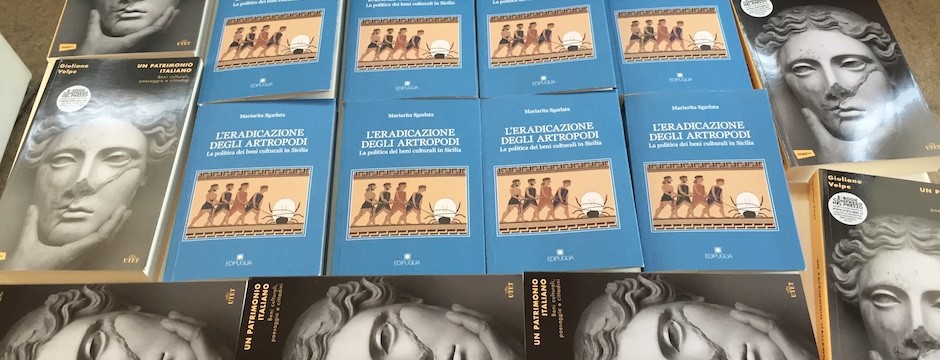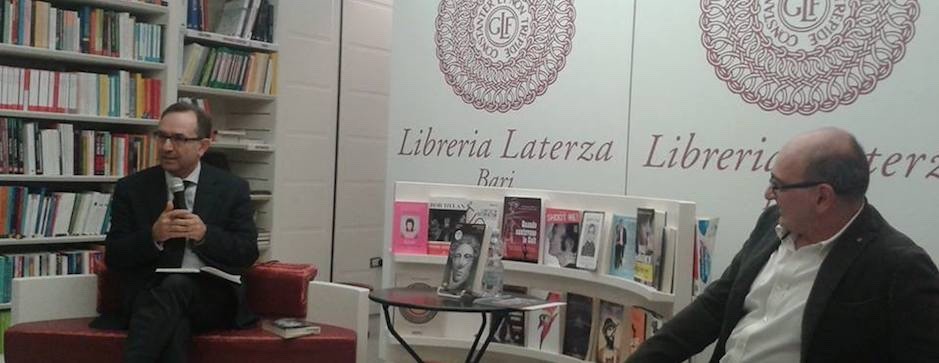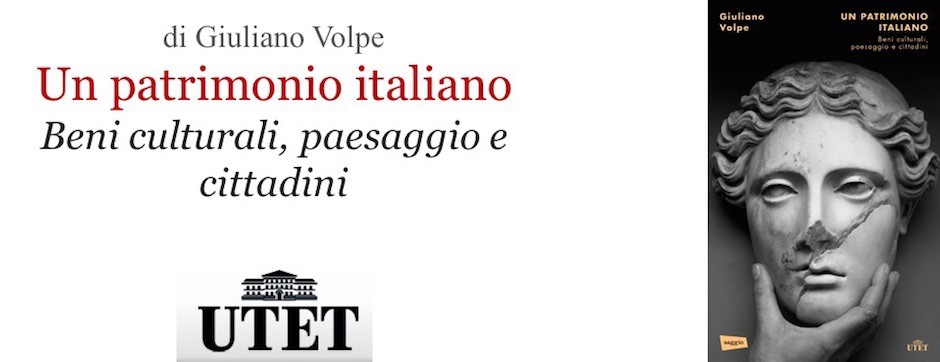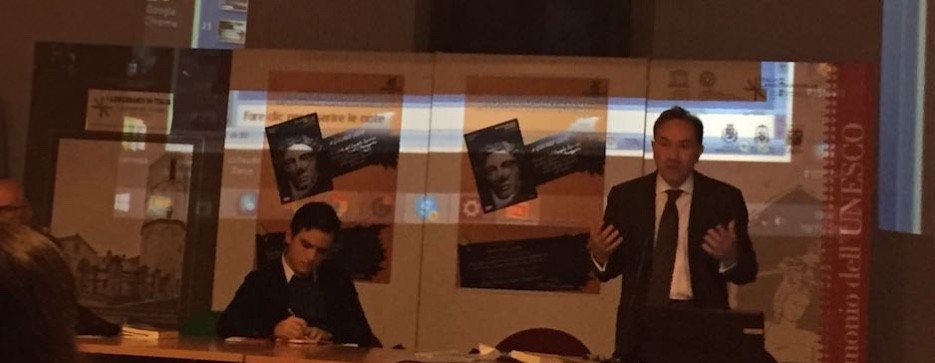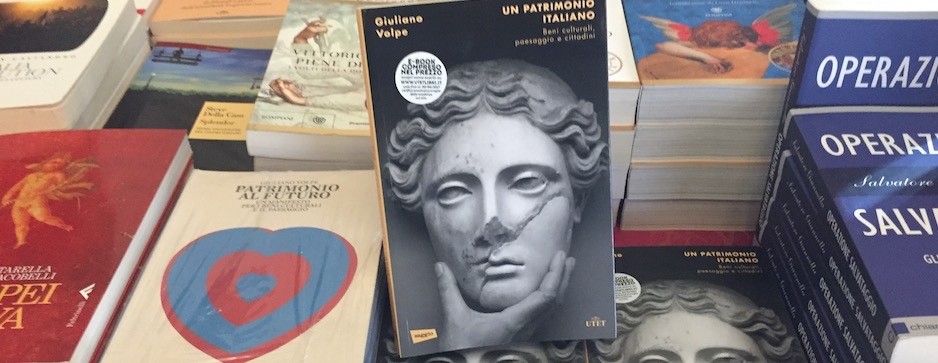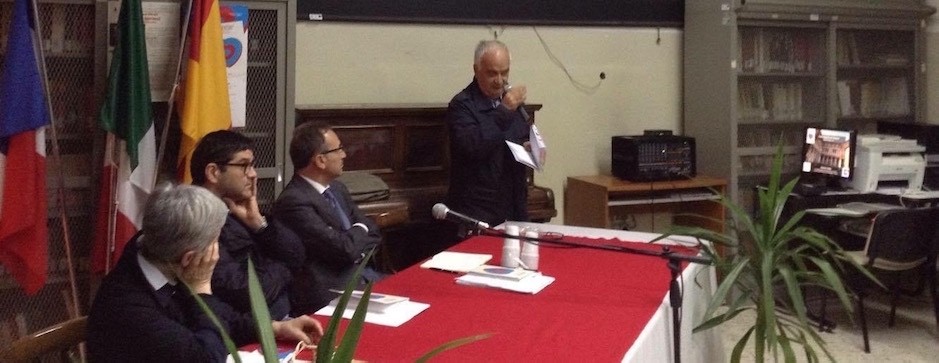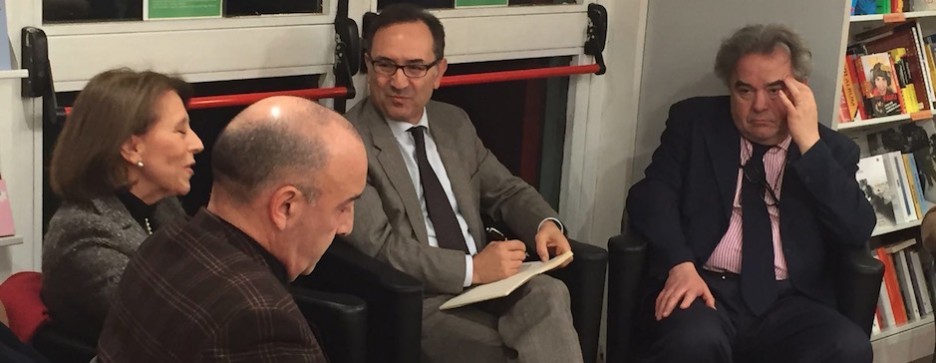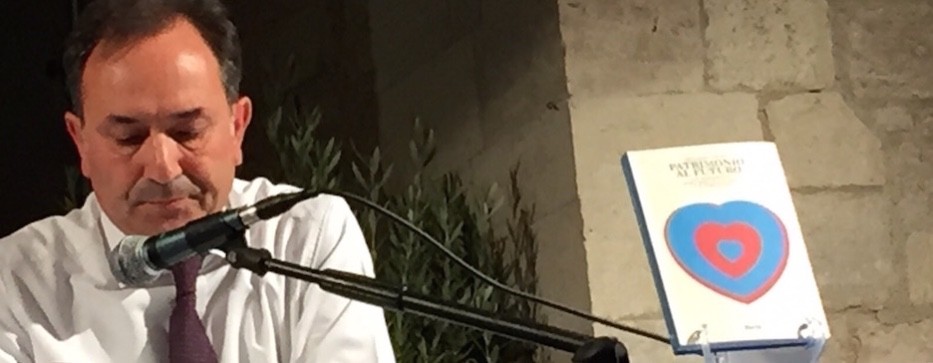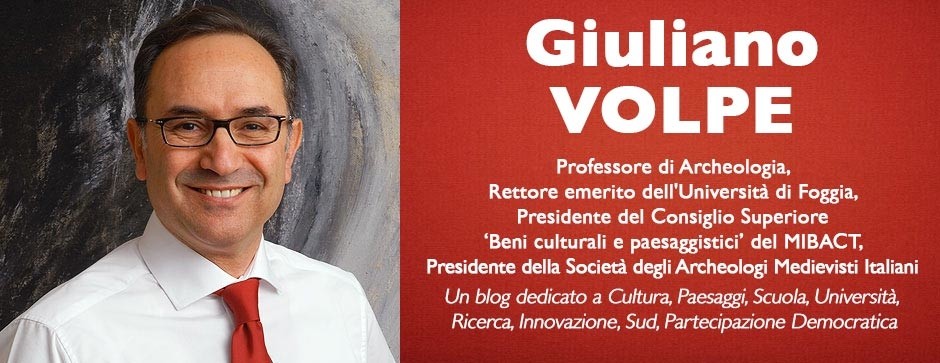Blog
L'infinita cialtronaggine con il dottorato in Italia
La vicenda del Dottorato di ricerca, cioè del livello più alto della formazione universitaria, inteso come avvio alla ricerca in vari ambiti, in Italia continua a essere altalenante, con un livello di confusione e di cialtronaggine che questo segmento strategico dell’alta formazione e della ricerca non meriterebbe.
Il Dottorato nel nostro paese ha continuamente cambiato assetto, fisionomia, significato. Chi scrive ha seguito come allievo il secondo ciclo, alla metà degli anni Ottanta. In questi giorni le università italiane stanno per chiedere l’accreditamento del quarantunesimo ciclo. Insomma, siamo in presenza di oltre quarant’anni di storia dell’Università italiana, con alti e bassi (più bassi che alti per la verità!). Quando chi scrive superò la dura prova di ammissione al Dottorato (uno scritto e un orale particolarmente impegnativi) ebbe la consapevolezza che si apriva la strada alla carriera universitaria. Ed effettivamente due dei tre allievi di quel corso sono poi diventati professori universitari, anche se dopo non poco precariato. Il corso era promosso da cinque università italiane, si avvaleva di un collegio di circa una quindicina di docenti delle varie università, aveva una struttura disciplinare molto ben definita (in quel caso l’Archeologia della Magna Grecia). I Dottorati erano in quegli anni più o meno tutti di questo tipo: disciplinari, nati dal concorso di varie università, pensati soprattutto per formare i futuri docenti universitari.
Poi il Dottorato ha cambiato più volte fisionomia, con fasi espansive e regressive, come una sorta di elastico che si allunga e poi si restringe. Si è progressivamente compreso che il Dottorato di Ricerca non dovesse essere limitato al solo mondo universitario, ma dovesse formare “ricercatori”, cioè persone capaci di studiare, di aggiornarsi, di ricercare, prescindendo dall’ambito lavorativo, comprese le imprese, la Pubblica Amministrazione, le professioni. Però il titolo non è stato mai veramente valorizzato, né dalle imprese (che solo in casi rari svolgono effettivamente attività di ricerca e innovazione: un limite questo che rappresenta uno dei grandi problemi del nostro sistema imprenditoriale!), né dalla Pubblica Amministrazione. Nel migliore dei casi è valutato come un titolo preferenziale. Eppure, ci sono stati casi virtuosi: la Regione Puglia della Giunta Vendola riuscì a realizzare un’operazione di reclutamento di dirigenti dottori-dottoresse di ricerca: il miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa, non solo sotto il profilo dell’efficienza, ma anche e soprattutto dell’apertura culturale, dell’innovazione e, in generale, della visione, è stato innegabile.
Chi scrive, come tanti altri colleghi, ha coordinato nel corso dei decenni almeno tre-quattro corsi di Dottorato di diverso tipo. So bene cosa sono e che livello di considerazione hanno i Dottorati in altri paesi. La fase forse più triste di questa lunga vicenda è stata rappresentata dai Dottorati di sede: corsi che mettevano (e a volte mettono) insieme le discipline più disparate, spesso all’interno dello stesso Dipartimento, con una malintesa idea di interdisciplinarità (che non ha nulla a che fare con discipline, che tra loro non dialogano affatto, solo per gestire poche borse, attribuite di solito a rotazione ai vari docenti!).
Più recentemente si è tornati, fortunatamente, a corsi promossi in convenzione o in consorzio, da varie università, dal CNR e da altri centri di ricerca. Con la legge 226 del 2021 sono nati anche i Dottorati industriali, organizzati con le imprese, e i Dottorati di Interesse Nazionale, che, come precisa la legge, contribuiscono «in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali».
Gli anni passati abbiamo conosciuto la “bolla” del PNRR con centinaia di borse a disposizione, molte anche pensate per la Pubblica Amministrazione, per il Patrimoni Culturale e per le Imprese. Alcuni Corsi sono passati da poche borse a bandire decine e decine di borse. I periodi all’estero, resi di fatto obbligatori (cosa assolutamente positiva) si sono moltiplicati così come i periodi in azienda o nella PA. I DIN sono cresciuti a dismisura. In generale è mancata una programmazione davvero strategica oltre, soprattutto, a una vera valutazione della qualità della formazione e della produttività dei dottorandi, dell’internazionalizzazione, oltre che del livello dei docenti coinvolti, mentre siamo stati sommersi dalla produzione di dati esclusivamente quantitativi e da una montagna di formalismi e di scartoffie, convenzioni, note di ogni tipo, verbali, piattaforme, scaricati sui coordinatori dei Corsi (che ormai svolgono quasi solo questo gravoso lavoro amministrativo, invece di dedicarsi interamente al coordinamento didattico e scientifico), e sugli uffici amministrativi delle università.
Soprattutto i Dottorati di Ricerca sono stati sempre più equiparati a normali corsi universitari, spesso con un eccessivo carico didattico e molto minore spazio alla ricerca, che deve prevedere spazi e tempi liberi. Anche il rapporto con le imprese o la Pubblica Amministrazione, pur essendo positivo, non può condannare solo a una formazione e una ricerca commissionata e applicata. Serve la ricerca libera, quella di base, quella scelta dal singolo dottorando in base ai suoi interessi e alle proprie vocazioni. Solo così c’è reale progresso di conoscenza, c’è vera innovazione, c’è crescita individuale del dottorando e dottoranda e dell’intera comunità scientifica. In caso contrario il Dottorato non ha senso, perde la sua reale funzione, muore.
Il quarantunesimo ciclo del dottorato sembra decretare la fine di questa fase espansiva e il ritorno, triste, alla dimensione locale. Le percentuali di mortalità dei DIN si annunciano elevatissime, perché solo pochi, in particolare quelli più tecnologici, legati alle imprese e ad altri progetti con grandi finanziamenti, potranno rispettare il limite delle trenta borse fissato dalla legge 226.
Si sperava che il Ministero dell’Università e della Ricerca riservasse un numero congruo di borse direttamente ai DIN, almeno a quelli ritenuti di maggior valore, strategici per il Paese, e riducesse il limite a venti borse, soprattetto per i Dottorati di ambito umanistico che fanno molta più fatica reperire borse finanziate o cofinanziate dall’esterno. La ministra Annamaria Bernini sembrava volesse prendere impegni in tal senso, ma nulla è successo: il decreto per il quarantunesimo ciclo è stato pubblicato in ritardo, non si sono modificate le norme, non si è previsto un fondo specifico per i DIN, mentre si è scaricata sui singoli Atenei la scelta: le Università sono in una fase di riduzione dei finanziamenti, con il recente taglio del Fondo di Funzionamento Ordinario, e non possono più disporre delle tante borse PNRR degli scorsi anni. Tranne poche eccezioni, si ritorna così a chiudersi in piccoli recinti locali, si preferisce gestire le poche borse in casa invece di destinarle a progetti con altre università, anche perché questo tipo di apertura non risulta premiata. I più danneggiati sono ovviamente i giovani in formazione che nei dottorati possono avere l’occasione di conoscere altri docenti, altre sedi, stringere rapporti con loro colleghi di altra formazione. Rapporti di amicizia e collaborazione che di solito restano vivi per sempre.
L’Italia continua a credere poco nel Dottorato di Ricerca (e in generale sull’Università). Eppure, in questi quarant’anni il Dottorato in Italia, nonostante i tanti problemi cui ho fatto cenno, e grazie all’impegno dei docenti e alla passione e creatività dei dottorandi e dottorande, ha formato eccellenti ricercatori e ricercatrici, che spesso sono stati e sono molto apprezzati all’estero, dove sempre più spesso i nostri giovani trovano accoglienza. Dopo un investimento durato anni, costato parecchio anche in termini di impegno e sacrifici, regaliamo le nostre migliori menti ai nostri concorrenti internazionali, peraltro attirando assai pochi giovani dall’estero, viste le tante incertezze e la confusione che regna da noi in questo ambito, come anche l’ADI (associazione dei dottorandi italiani) denuncia da anni.
Ministra Bernini, lei è anche una collega docente universitaria, immagino sia anche lei una dottoressa di ricerca: si occupi finalmente di questo segmento strategico dell’Università e del Paese, garantisca certezze e stabilità al sistema, introduca vere forme di valutazione della qualità, dia valore reale al titolo.
https://www.huffingtonpost.it/blog/2025/05/19/news/laltalena_del_dottorato_in_italia-19234898/Ultimi post
I sono notizia
So che questo post troverà molte persone ostili, o almeno stupite che io veda certe cose, ma rischio perché credo che questa serie sia molto...
La grazia
Stasera ho visto "La grazia" di Paolo Sorrentino, in una sala pienissima, in un cinema affollato (ed è già una buona notizia). E' ormai noto che...
Norimberga
Stasera ho visto un bel film: Norimberga, di James Vanderbilt. Film storico perché tratta un momento davvero storico come il processo di Norimberga, ma...
Father Mother Sister Brother
Ho visto al cinema “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch. Un bel film, molto poetico, che però ti lascia un senso di tristezza e a...